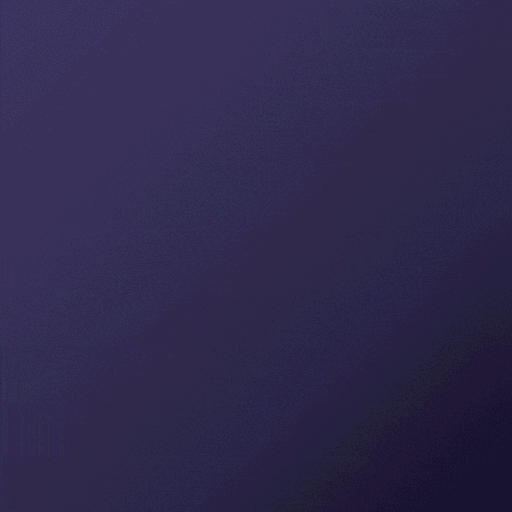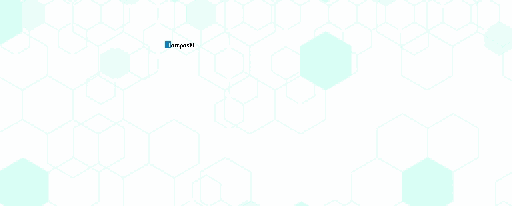L’industria aeronautica fa sempre più spesso uso di materiali biocompositi (prodotti dall’unione di resine da fonti rinnovabili e di fibre naturali per il rinforzo) per la realizzazione di parti dei velivoli. L’eterogeneità di questi materiali e la mancanza di fibre di carbonio al loro interno, tuttavia, rendono più complessa la loro gestione a fine vita.
Il progetto ELIOT
AIMPLAS, il Plastics Technology Centre e il centro di ricerca olandese TNO hanno condotto un’analisi approfondita delle diverse metodologie di riciclo dei biocompositi utilizzati nel settore aeronautico. Obiettivi dello studio erano la valutazione, su scala impiantistica pilota, delle alternative tecnicamente e finanziariamente praticabili e la promozione di tecnologie in grado di migliorare la sostenibilità dei processi produttivi del settore aerospaziale.
La ricerca è stata finanziata dal programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020, nel quadro dell’iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky e nell’ambito della convenzione di sovvenzione numero 886416.
I risultati
Dai test è emerso che la solvolisi e la pirolisi sono le soluzioni più idonee per la produzione su larga scala. La pirolisi, però, emette il 17% in più di anidride carbonica e consuma il doppio del calore rispetto alla solvolisi. Quest’ultima, infatti, al posto dell’energia termica utilizza alcuni solventi, che possono essere recuperati e riutilizzati nel processo.
Le prove sono state effettuate all’interno di un impianto di trasformazione con una capacità di dieci chilotonnellate di biocompositi all’anno. Sia per la pirolisi che per la solvolisi sono state necessarie ulteriori fasi di purificazione per poter utilizzare rispettivamente il liquido di pirolisi e il prodotto distillato. Altre tecnologie analizzate sono state il riciclaggio meccanico, la dissoluzione, la degradazione enzimatica, la gassificazione e il compostaggio.